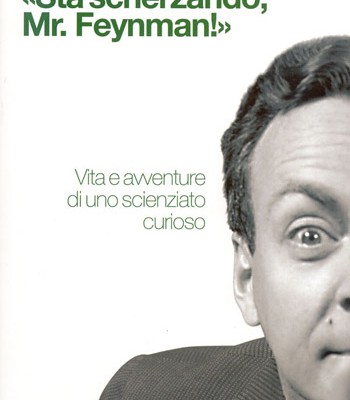David Foster Wallace ( sopra, nella foto) non ha nemmeno quarant’anni e si è guadagnato una solida fama di scrittore guida per le nuove generazioni. Dal momento del suo debutto, con La scopa del sistema, ha saputo dare una violenta sferzata al panorama letterario statunitense, dominato dalle retroguardie del minimalismo. I suoi libri sono percorsi dall’energia incontenibile dei grandi scrittori massimalisti, da Joyce a Pynchon, da Céline a Perec, con la sfacciata tendenza a ricreare continuamente un mondo sulle rovine del presente. Attraverso racconti, interviste immaginarie, reportage stralunati dal pianeta della fiera dell’Illinois o del turismo di massa, Wallace ha messo a punto una sgangherata ma lucidissima fenomenologia dei sentimenti surgelati degli Stati Uniti al giro del millennio. Infinite Jest, del 1996, è considerato, fino ad ora, il suo capolavoro, con tutto l’alone di paradossale sospetto che questo riconoscimento critico può generare. Come accade per i grandi romanzi enciclopedici, si tratta soprattutto di un labirinto di storie, una rete di piccole narrazioni ad incastro.
In un’intervista, Wallace ha dichiarato di aver scritto Infinite Jest con l’intenzione di comunicare il senso di un crollo imminente. E in effetti questo libro di millequattrocento pagine, uno degli eventi editoriali degli ultimi anni, sembra sempre sul punto di accartocciarsi su se stesso, di implodere e consumarsi lasciando in mano al lettore un mucchio di carta da riciclare al più presto. L’impressione che si prova ad un primo impatto è quella di un’irritante abilità nel tenere la tensione alle stelle una riga dopo l’altra, raccontando vicende all’apparenza sconclusionate e grottesche, osservate attraverso la lente deformata dell’umorismo acido dell’autore. Ma Wallace riesce, accumulando dettagli insignificanti e ramificando la vicenda in un intrico di traiettorie di vita distanti nel tempo e nello spazio, a creare addensamenti e stratificazioni, dando vita a quelle improvvise accelerazioni che rendono davvero vertiginoso il ritmo avvolgente di questo romanzo-mondo.
Perché di un mondo si tratta senza dubbio, con regole proprie, con strumenti percettivi autonomi, con media giunti ad un grado di sviluppo indipendente. Con un’evoluzione nella tossicologia e negli stati alterati della mente che potrebbe costituire una ramificazione, una biforcazione possibile del nostro futuro. Con terapie di disintossicazione e universi medici che coincidono quasi interamente con i nostri, se non fosse per piccoli particolari fuori posto, frammenti clinici che s’ingrandiscono, crescono in maniera ipertrofica generando un groviglio evolutivo che cresce accanto al nostro futuro come una conferma sperimentale delle teorie di Gould. Si trova infatti in Wallace una pignoleria fastidiosa nell’uso del dizionario, nella creazione di nuovi filoni di ricerca, accuratamente classificati e definiti in rapporto a quello che potremmo definire lo stato della tecnologia fino ad oggi.
Come uno scrittore di fantascienza, Wallace ci costringe ad indossare protesi, prolungamenti sensori bizzarri e inconsueti, facendoci familiarizzare con rami della fisica ottica che si annodano, attraverso percorsi diagonali, alle traiettorie non lineari delle palline da tennis o alle percezioni fluttuanti di una drogata ossessionata dalla sostanza che dà senso alla sua vita. E tuttavia non si tratta di un libro difficile, intellettuale o dotto. L’impressione di onniscienza che si diffonde qua e là viene stemperata da una fortissima tensione nervosa che s’insinua nel lettore. La litania ipnotica degli elenchi – di malattie deturpanti o di regole di comportamento o di allenamenti tennistici o di semplici nomi che si fatica ad attribuire in un mare di caratteristiche fluttuanti – non è sfoggio enciclopedico ma strategia indiretta per la penetrazione sottocutanea di scosse narrative. Wallace procede ondeggiando, con l’attenzione delirante per i particolari di un paranoico. Finché la catena delle ossessioni o delle dipendenze arriva al punto d’implosione facendo scattare un cambiamento di ritmo, un controtempo che, come accade ai giovani tennisti, consente l’accesso ad un plateau superiore.
Questo libro parla, tra l’altro, di un film misterioso che cancella i desideri dello spettatore, in una sorta di ipnotico intrattenimento definitivo. Infinite Jest, scherzo infinito, è proprio il titolo di questo film che coinvolge i personaggi del libro in una caccia dai risvolti politici. Ma lo scherzo definitivo escogitato da Wallace consiste nella costante capacità di catturare il lettore attraverso frammenti impercettibili di scrittura. Il dettaglio avvolge il disegno complessivo, lo rinchiude in un anello discorsivo che si avvita come un nastro di Moebius. Si assiste alla sfilata di una galleria di freaks incredibilmente normali: tennisti ossessionati dalla semantica, ragazzi macrocefali che girano con un’inseparabile telecamera, star della radio che non si tolgono mai il velo, giganteschi travestiti giornalisti e agenti segreti, spie québechiane in sedia a rotelle, guru surreali. Viene snocciolata una lista di manie e terrori che riguardano vedove nere, scarafaggi, formiche, allucinogeni, orari, tatuaggi, forni a microonde, giochi di guerra nucleari, patologie del marketing televisivo…In un mondo in cui gli Stati Uniti hanno cambiato nome, il calendario viene deciso dagli sponsor e le gabbie mentali e fisiche si confondono. E s’incomincia a pensare che il senso del viaggio all’interno del microuniverso creato da Wallace si nasconda negli spazi bianchi, nelle note alla fine del volume, nelle risonanze tra eventi senza importanza. Nella filmografia immaginaria di James O. Incandenza, fondatore di un’accademia di tennis, protagonista del libro, anello mancante e punto di rottura che attraversa l’intera vicenda.
David Foster Wallace, Infinite Jest, Little, Brown and Company, 1996; trad. di Edoardo Nesi, Fandango, Roma, 2000.