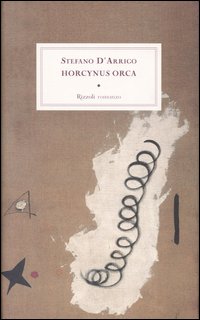Michel Tournier pubblica Le Roi des aulnes nel 1970. Un paio d’anni prima era uscito il suo primo romanzo, il folgorante Vendredi ou les limbes du Pacifique, rilettura rovesciata della storia di Robinson Crusoe, che aveva ricevuto da più parti giudizi entusiastici. In Italia Calvino ne caldeggiò l’uscita presso Einaudi, scrivendo anche una lucida postfazione al libro. Vendredi aveva rivelato un autore già maturo, con una scrittura ricca, di impianto classico eppure fortemente destabilizzante, aperta agli influssi della psicoanalisi e dell’antropologia. Un romanzo che senza dubbio risentiva del dibattito sulle scienze umane aperto da Lévi-Strauss e che rivelava una abilità sorprendente nell’utilizzo della struttura a palinsesto. Letteratura di secondo grado, dunque, un po’ come gli esperimenti oulipiani di Perec o le ricerche formali del nouveau roman (da Robbe-Grillet a Butor e Simon). Ma Tournier si dimostra scrittore dotato di una forza inventiva sorprendente e senza termini di paragone: la sua ricerca sul romanzo non si confonde minimamente con il formalismo di una certa via transalpina alla letteratura. Tournier, con la sua aria da classico “deviante”, si propone subito come uno scrittore eccentrico rispetto alle grandi correnti di sviluppo del romanzo europeo.
Le Rois des aulnes prende tutti in contropiede, estremizzando il procedimento compositivo del libro precedente. La geometria che ancora sorreggeva la parabola di Venerdì e Robinson si ingarbuglia e sprofonda nella densità magmatica dei simboli. La matrice è, ancora una volta, letteraria (una poesia di Goethe), ma si tratta solo di una traccia, uno schizzo narrativo che permette di intrecciare una serie di rinvii tematici di una densità impressionante. Attorno alla poesia di Goethe germogliano ramificazioni narrative quasi inesauribili: il tema dell’orco rapitore di bambini; la questione del nazismo e della sua capacità di raccogliere consensi “facendo massa” e trasfigurando gli individui in un corpo compatto e inarrestabile; le inversioni e gli investimenti pulsionali non inquadrabili entro alcuna cornice di normalità. E soprattutto il tema della “Foria”, del trasporto, che percorre tutto il romanzo in una molteplicità di variazioni e ricombinazioni simboliche.
Scegliendo di assumere il punto di vista del garagista parigino Abel Tiffauges, Tournier provoca il lettore e lo costringe ad un’adesione quasi insopportabile allo sguardo del protagonista (e Calvino, disturbato, lasciò che la traduzione del romanzo passasse alla Mondadori). Tiffauges è sgradevole, anomalo, distante. È dominato da passioni perverse, intollerabili: in sospetto di pedofilia, è un feticista, morbosamente attratto dagli animali e dagli aspetti viscerali dell’essere umano. Quindi è zoofilo, necrofilo, coprofilo, ma sempre lateralmente, di straforo, come se tutti questi oggetti di attrazione scivolassero via in una passione superficiale. Tiffauges è un mostro, ma in senso etimologico: monstrum è il prodigio, l’essere che suscita meraviglia e che potrebbe dar vita a una nuova specie (e monstrum è il vecchio alce che incontra durante la prigionia, lo Unhold, il bruto, lo sgraziato, ma anche il mago o il diavolo) . Le sue attrazioni nascondono sempre la possibilità di un’inversione supplementare, come nel cervo, il cui sviluppo sessuale, che punta verso il basso, determina la grandiosità del palco di corna che lo trascina in alto, verso il cielo. Prigioniero di guerra, Abel non esita a passare dalla parte dei tedeschi per inseguire il proprio destino in una rete di rinvii simbolici e di improbabili richiami. Uno strano tropismo lo porta ad Est, tra le paludi della Prussia orientale, in mezzo a branchi di cervi e sanguinose battute di caccia, in una waste land punteggiata di ontani neri e inquietanti. Eppure non si riesce ad evitare la fascinazione: lasciando filtrare i dettagli dell’universo interiore del suo personaggio Tournier ci spinge ad immedesimarci. Il lettore è costretto a condividere alcuni tratti di questo viaggio inarrestabile e allucinato.
Nel saggio autobiografico Le Vent Paraclet Tournier rivela che tra le fonti di ispirazioni primarie del libro, accanto al grande amore per la terra tedesca, ci furono L’arte della fuga di Bach e il Canto dei giovani ebrei di Karl-Heinz Stockhausen. E infatti Le Roi des aulnes è un libro molto musicale, pieno di suoni e versi, canti e grida. Abel Tiffauges rimane sempre in ascolto – dall’infanzia trascorsa in un collegio fino all’apocalisse che devasta la Prussia orientale – ipnotizzato da un richiamo che sembra segnare i momenti di svolta della sua vita. Urlo collettivo di una nazione votata all’annientamento o richiamo di Bram, il cervo, questo suono è una pista sonora, una mappa acustica che Tournier sovrappone al percorso reale compiuto da Tiffauges.
Dagli “scritti sinistri”, prima inversione di Tiffauges che rovescia il modo di scrivere abituale, alle apparizioni grottesche e sulfuree degli orchi (Hermann Goering, gran cacciatore del Reich; l’orco di Kaltenborn, direttore della scuola per giovani nazisti; e soprattutto, sullo sfondo, Hitler, il grande orco al quale la nazione sacrificava ogni anno, come dono di compleanno, un’intera generazione di ragazzini) seguiamo con gli occhi del garagista una parabola seducente e spaventosa. E l’incontro finale, risolutivo, con il bambino ebreo Ephraïm offre a Tiffauges la chiave per l’inversione definitiva. Tutto il viaggio cambia di segno e le tracce benigne della Foria (le macchine, il cavallo, il cervo, le simmetrie dei gemelli) si compongono nella paraforia, il trasporto malvagio dei campi nazisti. A Tiffauges non resta che assumere direttamente la propria vocazione (o pulsione) forica. Sarà lui il cavallo, l’orco benefico destinato a raccogliere il peso di Ephraïm, stella d’oro a sei punte nella notte nera dell’astroforia.
di Nicola Gaiarin